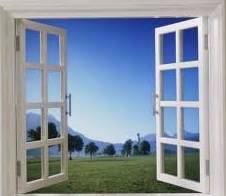
55f1af74ed6d51549d7d4b31853fd65a

L’igienicità di una casa è un argomento poco conosciuto e di solito interpretato come aspetto di ordine e pulizia in senso lato. È, al contrario, un argomento di studio ed evoluzione che ha indotto il legislatore a interessarsene costantemente nel tempo, anche l’applicazione dell’Art. 32 della Costituzione Italiana: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,….”.
Uno dei punti fondamentali verso cui si orientò il legislatore, fu quello del rapporto di areazione e illuminazione, essendo noto ormai il nesso tra carenza di luce ed aria con il prevalere di malattie.
Per aria inframurale o microclima o aria indoor si intende l’insieme dei componenti chimici (azoto, ossigeno, anidride carbonica etc.) e fattori fisici che caratterizzano l’aria degli ambienti confinanti che definiscono uno stato di comfort (benessere) individuale e collettivo.
I fattori fisici sono strettamente correlati alla tipologia costruttiva dell’edificio, all’ampiezza dell’ambiente, alla presenza di finestre in numero adeguato, al ricambio naturale dell’aria e sono 4, legati tra di loro (nel senso che non si può considerarne uno solo tralasciando gli altri tre): temperatura dell’aria, calore radiante (onde elettromagnetiche di calore che vengono emesse dai corpi), umidità relativa (quantità di vapore acqueo), velocità dell’aria (movimento dell’aria).
L’umidità è la percentuale di vapore acqueo presente nell’atmosfera ed esistono vari modi di essere misurata. In termini pratici, è un valore che influisce molto sul nostro stato di benessere e sulla nostra percezione della temperatura e del clima, quindi del freddo o del caldo. La percentuale generale di umidità nell’aria varia da una zona all’altra dell’Italia: nel nostro Paese, l’umidità può variare tra il 30% e il 100%.
L’umidità non basta a determinare le condizioni ambientali ideali o errate, ma è il suo abbinamento con la temperatura a creare condizioni di disagio o benessere, l’una e l’altra hanno dei valori ideali entro cui trovarsi, in combinazione fra loro. In pratica, ogni temperatura ha un relativo valore di umidità che assicura in quel caso il massimo comfort, dentro casa. Immaginando una persona adulta, in situazione di riposo, le temperature con relativi tassi di umidità ideali sarebbero:
- con 18° di temperatura, un’umidità del 100%;
- con 19° di temperatura, un’umidità dell’80%;
- con 20° di temperatura un’umidità del 60%;
- con 21,5° di temperatura, un’umidità del 40%;
- con 23° di temperatura, un’umidità del 20%.
Maggiore è il tasso di umidità, maggiori sono le particelle di vapore acqueo che circolano nell’ambiente, e giacché le goccioline di umido sono degli ottimi “carriers” per germi vari che “aggrappati” sulle goccioline possono viaggiare anche per lunghe distanze, è logico concludere che maggiore è l’umidità ambientale, maggiore è la probabilità di contrarre una malattia infettiva.
Quando il benessere termico inizia a venire meno, s’inizia a parlare di viziatura dell’aria, definita come un’alterazione dell’originario stato di benessere ambientale (comfort) dovuta a modificazione dei parametri fisici e chimici. E’ causata soprattutto da un eccessivo uso degli ambienti confinanti da parte di un’utenza numerosa e per un lungo periodo di tempo.
Può essere dovuta anche a : stati morbosi, funzionalità di alcune ghiandole, attività svolta, strumenti e oggetti d’uso presenti. Le possibili conseguenze sull’essere umano sono: diminuzione del rendimento lavorativo, incapacità di concentrazione, ma anche cefalea, bruciore agli occhi o lacrimazione, irritazione delle vie aeree, delle mucose e della superficie epidermica, possibile aumento di incidenti ed infortuni,oppure lievi sintomi di tipo allergico ma che possono arrivare al collasso.
Il tutto può dare origine alla sindrome dell’edificio malato o sick building syndrome. Per prevenire che ciò avvenga si parla di quota di ventilazione o cubo d’aria, per il quale non s’intende un metro cubo d’aria, ma corrisponde all’incirca a 22,5 l/h di aria per un soggetto adulto, a riposo, che non faccia lavori pesanti, ossia è la quantità di aria che un soggetto deve ricevere in maniera tale che la concentrazione di anidride carbonica (CO2) in quell’ambiente non superi l’1%. Questo negli anni passati spinse a costruire case con ambienti che avevano soffitti estremamente alti (3,20 m) e tanto più nelle strutture sanitarie (5-6 m) per via dell’aumentata attività metabolica del malato, per la teoria delle antropotossine etc.
Oggi tutto ciò sarebbe uno spreco enorme, considerando anche l’uso sempre maggiore dell’aria condizionata. Allora se si devono fornire 22,5 l d’aria / h e non ci sono, a causa della grandezza degli ambienti confinanti, o del numero di persone che vi lavorano che si fa? Si aprono le finestre! Qui però si pone un ulteriore problema in quanto la velocità dell’aria non deve superare determinati valori, sia d’inverno che d’estate, perché comporterebbe un raffreddamento del corpo, e una perdita di benessere termico e quindi la velocità dell’aria deve essere moderata.
L’unica soluzione è stabilire quanti ricambi d’aria all’ora sono necessari, sempre mettendoli in relazione all’attività svolta, da ciò ne consegue che un lavoro sedentario in un abitazione o in un ufficio ha al massimo la necessità di 2 ricambi / h; nelle sale di degenza ospedaliera si fanno fino a 2-3 ricambi / h, fino ad arrivare nelle sale operatorie dove si fanno 10-15 ricambi / h (questo perché in quei luoghi c’è anche il problema di un accumulo degli anestetici ed altri gas medicali nell’ambiente).
N. ricambi d’aria ottimali in diversi ambienti confinati
1-2 > Abitazioni ed uffici privati
2-3 > Stanze degenza ospedaliera
4-5 > Aule scolastiche, luoghi di riunione, uffici pubblici
6-8 > Stabilimenti, ristoranti, sale da ballo
8-10 > Locali con produzione di odori e vapori, gabinetti e cucine
15 > Sale operatorie ospedaliere
Un ulteriore causa di malessere, all’interno degli ambienti di vita, può essere il tasso di anidride carbonica o diossido di carbonio, che risulta molto variabile negli ultimi tempi. In particolare le attività umane (industria, inquinamento, combustione, deforestazione, ecc.) hanno prodotto nell'ultimo secolo un grosso incremento di questa percentuale.
La concentrazione di tale componente, infatti, sembra essere, insieme a quella del metano ed altri gas, uno dei responsabili principali dell'effetto serra. L’anidride carbonica è un gas asfissiante in quanto, pur non essendo tossico per l'uomo, si sostituisce all’ossigeno dell’aria. Quando determina una diminuzione dell'ossigeno a valori inferiori al 17 % in volume, produce asfissia. Inoltre è un gas che accelera e stimola il ritmo respiratorio. La deficienza di ossigeno e/o l'eccesso di anidride carbonica possono condurre alla perdita di conoscenza e alla morte per asfissia.
Quando la concentrazione dell'ossigeno scende intorno al 15%, l'attività muscolare diminuisce, si ha difficoltà nei movimenti. Quando la concentrazione dell'ossigeno è tra il 10 e il 15% l'uomo è ancora cosciente, anche se, e non necessariamente se ne rende conto, commette valutazioni errate. A concentrazioni di ossigeno tra il 6 e il 10% si ha collasso. Sotto il 6% cessa la respirazione e la morte per asfissia ha luogo nel giro di circa 6 minuti. Quindi, un'atmosfera che contiene oltre il 5% di biossido di carbonio è asfissiante per gli esseri umani e per gli animali.
L’Inquinamento dell’aria non è responsabile solo di malessere o patologie che influenzano lo stato di buona salute, ma anche di un aumento della mortalità. L’istituto nazionale per la ricerca sul cancro ha stabilito che c’è un aumento dal 20 al 40 % del rischio di tumore al polmone e il 50-60 % dei composti cancerogeni, che sono poi responsabili di tutti i problemi alle vie aeree, vengono fondamentalmente dal traffico e dal riscaldamento domestico. In Italia si calcola in media che vi sia ca. 15000 morti/anno in più legati all’inquinamento atmosferico o comunque ambientale.
Nelle grandi città si parla in media di almeno 8-10 morti al giorno in più legati al riscaldamento e all’inquinamento atmosferico in generale.
Dott.ssa Lucia Peduto


















Commento (0)
Devi fare il login per lasciare un commento. Non sei iscritto ?